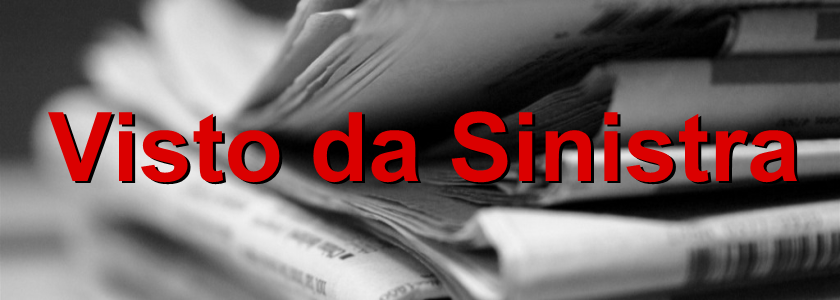La legalità costituzionale, prima di tutto. Sta accadendo qualcosa che non ha precedenti nell´intera storia repubblicana. Si dubita, con fondate ragioni, della legittimità stessa delle leggi elettorali, dunque dello strumento al quale sono affidate le sorti della democrazia rappresentativa. Questo non avviene per forzature di parte. Deriva da quel che sta scritto in una delle sentenze con le quali la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibili i referendum elettorali e che, nell´euforia referendaria, era stato trascurato. Non è un dettaglio, ed è ben più che un segnale d´allarme. Dopo aver ricordato di non potersi occupare in questo momento della costituzionalità dell´attuale legge elettorale, né di quella che risulterebbe qualora i referendum fossero approvati, i giudici costituzionali scrivono: "L´impossibilità di dare, in questa sede, un giudizio anticipato di legittimità costituzionale non esime tuttavia questa Corte dal dovere di segnalare al Parlamento l´esigenza di considerare con attenzione gli aspetti problematici di una legislazione che non subordina l´attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una quota minima di voti e di seggi". Un vizio, questo, che non riguarda soltanto la legge che deriverebbe dal referendum, ma "è carenza riscontrabile già nella normativa vigente", dunque nella legge con la quale andremo a votare in aprile.
Che cosa vuol dire tutto questo? Che sulle prossime elezioni si allunga appunto l´ombra dell´illegittimità. Le Camere risultanti dal voto di aprile verranno costituite con un meccanismo sul quale sollevano dubbi non critici malevoli, ma la stessa Corte. La "porcata" di Calderoni e la "trovata" dei referendari sono accomunate da un dubbio che riguarda la loro compatibilità con il sistema costituzionale.
Come uscire da questa situazione? Da molte parti si prospettano ricorsi, conflitti tra poteri dello Stato. Ma, date le caratteristiche delle leggi elettorali, è quasi impossibile sanare quel vizio d´origine. E così l´intero nostro sistema istituzionale è destinato a funzionare in condizioni di "convivenza con l´illegalità", estendendosi ad esso una regola che vige da tempo in molte aree e settori del nostro paese. L´unico rimedio sarebbe la rapida approvazione di una nuova legge elettorale, subito dopo il voto. In questo modo, però, il nuovo Parlamento sarebbe immediatamente delegittimato, l´annunciata "fase costituente" avrebbe basi fragilissime e non sarebbero infondate le richieste di tornare al voto con una legge finalmente conforme alla Costituzione. Sembrerebbe che non vi sia alternativa: convivere con l´illegalità al massimo grado, quello costituzionale, o rassegnarsi ad una fase confusa e instabile. Questo è l´ultimo lascito della cosiddetta Seconda Repubblica, frutto dell´imprevidenza di alcuni e dell´irresponsabilità di molti.
L´illegalità costituzionale non si ferma qui, ma si estende all´intero sistema della comunicazione televisiva, dunque ad una componente ormai essenziale del processo democratico. Di nuovo, la denuncia della stessa illegittimità formale del nostro sistema non viene da critici prevenuti, ma dal vertice delle istituzioni europee, la Corte di Giustizia e la Commissione. La prima ha giudicato illegittima la mancata attribuzione delle frequenze spettanti all´emittente televisiva Europa 7, con una inammissibile chiusura del mercato e un pregiudizio per il pluralismo della comunicazione. E la Commissione ha da tempo avviato una procedura d´infrazione contro l´Italia, ritenendo incompatibile con le regole europee la legge Gasparri, dunque la normativa che sta alla base dell´attuale sistema. Questa situazione, per sé in contrasto con qualsiasi assetto democratico, diventa particolarmente grave nel nostro paese dove, come tutti sanno, si traduce nell´attribuzione di un indebito vantaggio ad una delle parti della contesa elettorale.
Le infinite anomalie italiane si intrecciano sempre più strettamente, rischiano di soffocare la democrazia e certamente producono sfiducia crescente da parte dei cittadini elettori. Che, per la seconda volta, si troveranno radicalmente espropriati della possibilità di scegliere i loro rappresentanti. Le liste bloccate saranno confezionate da una ventina di persone, alle quali è stato così trasferito un potere incontrollato di designare quasi mille parlamentari.
A questa ulteriore distorsione potrebbe esser posto parzialmente rimedio se, a differenza della volta passata, le oligarchie politiche facessero una duplice operazione. Da una parte, dovrebbero adoperare il loro enorme potere per rinnovare davvero la classe dirigente, con l´occhio alla competenza e all´effettiva rappresentatività, invece di perseverare nell´abitudine di promuovere famigli, clienti, yesmen, bevitori di spumante, mangiatori di mortadella, espositori di striscioni ormai vietati anche nelle curve degli stadi. Dall´altra, dovrebbero avviare una operazione di ripulitura che ripristini la legalità attraverso una rigorosissima valutazione della moralità pubblica e dei precedenti penali dei singoli candidati.
Sembrano due missioni impossibili, e forse lo sono. Ma la fiducia dell´opinione pubblica, dunque il suo ritorno alla politica e non la resa alle suggestioni dell´astensione e dell´antipolitica, passa proprio attraverso la ricostruzione della moralità pubblica, la fine della politica come mondo separato, sciolto dall´osservanza d´ogni regola, portatore più che di privilegi di vere e proprie immunità.
Molte indicazioni recenti vanno nel senso opposto. Prendiamo come esempio il caso Cuffaro. Sembrerebbe che le sue dimissioni siano state determinate non da una pesante condanna, ma da un vassoio di cannoli. Presente alla lettura della sentenza, il Presidente della Regione siciliana ha manifestato tutta la sua soddisfazione per essere stato assolto dall´imputazione di concorso esterno in associazione mafiosa, con una allegria che lasciava allibito chi aveva appena ascoltato una condanna a cinque anni con interdizione perpetua dai pubblici uffici. Intorno a Cuffaro si strinsero il suo partito e l´intero centrodestra. Poi l´imprevisto, barocco arrivo dei cannoli, e l´inevitabilità delle dimissioni. Dovute, dunque, ad un eccesso nei festeggiamenti, non a sensibilità istituzionale (si annunciava un decreto di rimozione). Ma il suo schieramento politico continua a presentarlo come vittima di una persecuzione giudiziaria, mentre quel processo, come dimostrano i molteplici colloqui di uomini della politica con esponenti mafiosi, è la prova drammatica di una politica che al mondo della criminalità non chiede soltanto un "appoggio esterno", ma con esso tende a compenetrarsi.
Come dimostrano questo ed altri casi, i tentativi di recuperare una legalità perduta da tempo sono affidati soltanto ai giudici, con le inevitabili distorsioni che questo comporta. Ma queste distorsioni, come ripeto da anni, derivano dal modo in cui il ceto politico ha deciso di difendersi, azzerando ogni sua responsabilità, sottraendosi a quelle minime regole deontologiche che qualsiasi professione (avvocati, medici, ingegneri) deve rispettare.
Da tempo la responsabilità politica è scomparsa. Quando si censura il comportamento di un politico, ormai la risposta corrente è "non vi è nulla di penalmente rilevante". Così non solo si confondono codice penale e regole della politica. Si fa diventare la magistratura l´esclusivo e definitivo giudice della politica: e questo accade non per una volontà di potenza dei giudici, ma per le dimissioni della politica da uno dei suoi essenziali compiti. Un establishment che voglia davvero essere tale, e voglia conservare credibilità di fronte all´opinione pubblica, dev´essere capace di escludere non solo chi viola le norme penali, ma chiunque trasgredisca le regole di trasparenza, correttezza moralità, riducendo la politica solo a spregiudicata gestione del potere.
Parlando di legalità, e del suo ripristino, è lecito fare un accenno anche alle questioni "eticamente sensibili"? O questa è una inaccettabile caduta nel laicismo? Un solo caso. In un clima da crociata, e di fronte a prescrizioni sempre più perentorie delle gerarchie ecclesiastiche, amministratori locali vogliono imporre le loro regole per l´interruzione della gravidanza. So bene che citare Zapatero è come parlare del Diavolo. Ma uno Stato dev´essere capace di rivendicare quelle che sono le sue proprie competenze, non delegabili a nessun altro. Solo così i cittadini possono continuare a percepire chi davvero esercita la sovranità, qual è la fonte delle regole, ed essere pronti a rispettarle.
di Stefano Rodotà da la Repubblica del 7 febbraio 2008